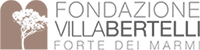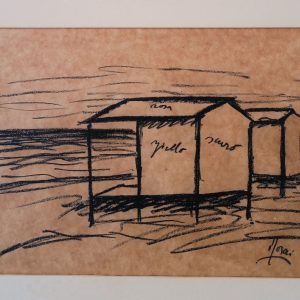OTTONE ROSAI (1895-1957)
Nasce il 28 aprile 1895 a Firenze, il padre Giuseppe desiderava che il figlio proseguisse la conduzione familiare di una bottega d’antiquariato con annesso laboratorio, lasciatagli dal nonno. Di differente opinione è Ottone che dapprima si iscrive, per un breve periodo, all’Istituto d’Arti Decorative di piazza Santa Croce, e successivamente, frequenta il Regio Istituto di Belle Arti. Non conclude gli studi, in quanto viene cacciato dall’istituto dopo un acceso diverbio con un professore.
Decide di continuare la carriera di artista come autodidatta, riuscendo ad esporre una sua prima mostra in un locale di via Cavour a Firenze nel novembre del 1913. In quell’occasione, per una fortunata coincidenza della vicina mostra dei futuristi del gruppo Lacerba nella stessa strada, conosce Papini, Marinetti, Boccioni, Palazzeschi, Carrà e Severini. Sucita l’ammirazione del gruppo, in particolare, di Ardengo Soffici che da quel momento diverrà per lui amico e mentore.
Con lo scoppio della prima guerra mondiale, Rosai nel 1915 si arruola come volontario ottenendo numerosi riconoscimenti per atti eroici. Finita la guarra, il rientro in società è difficile: politicamente è affascinato dall’entusiasmo di un giovane Benito Mussolini entrando a far parte delle squadre d’azione. Quello che ne risente è la sua pittura, le influenze del periodo difficile sono evidenti, abbandona le influenze futuriste e del cubismo per addentrarsi in una fase realista dove ritrae i suoi familiari o nature morte.
Nel 1920 espone alcuni tra i suoi lavori più riusciti nelle sale di Palazzo Capponi, a Firenze, elogiati pubblicamente da Soffici e De Chirico.
Nonostante la ripresa soddisfacente della carriera, un grave lutto oscurerà ulteriormente il periodo: il padre muore suicida, gettandosi nell’Arno, poiché oppresso dai debiti. Spetta ad Ottone occuparsi della madre e della sorella, ma non mancano le difficoltà finanziarie.
A poco servono gli aiuti di Soffici con l’alestimento di due mostre per l’amico. Ottone si trova costretto a svendere alcune delle sue opere più belle. Conclude nel 1929 la collaborazione come illustratore ad alcune testate dell’epoca fascista, poiché si ritiene tradito dalla sottoscrizione dei Patti Lateranensi da parte di Mussolini a conferma che l’anticlericalismo, da lui tanto osannato del primo Mussolini, è concluso.
Nel 1931 è autore di un opuscolo polemico Alla Ditta Soffici-Papini & Compagni, che incrina fortemente i rapporti di amicizia.
Vista la disastrata situazione economica, decide di affidare la direzione delle finanze e della bottega alla moglie, nel tentativo di dedicarsi nuovamente con impegno, alla pittura. Ottiene successo con la mostra di Palazzo Ferroni del 1932 e, nel 1934 partecipa alla Biennale di Venezia. Nel 1942 gli viene assegnata la cattedra di pittura dell’Accademia di Firenze. Dopo l’8 settembre 1943, viene aggredito da un gruppo di antifascisti.
Esporrà nuovamente attorno agli anni cinquanta, affacciandosi ad un ambito internazionale con rassegne a Zurigo, Parigi, Londra, Madrid. Partecipa alle edizioni della Biennale di Venezia del 1952, dove gli viene dedicata un’intera sala, e del 1954. Alla fine di quest’anno si presentano i primi problemi al cuore.
Nel 1957 si reca ad Ivrea, presso il Centro Culturale Olivetti, per curare personalmente una sua importante rassegna antologica. Vi si reca il giorno prima dell’inaugurazione il 13 maggio, ma di notte, mentre si trova nell’albergo che lo ospita, è colto da infarto e muore.
Benedetta Veschi